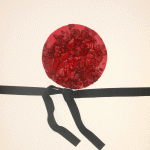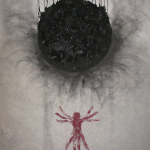Qualcuno l’ha definito l’Yves Klein italiano. Sarà per quel blu che spalma sulle sue opere al vivo, unico decoro su fanciulle che presenta come mamma le ha fatte. Ma oltre all’azzurro c’è il carbone, a raccontare i nostri misfatti ecologici e mettere in guardia sul futuro possibile per questo mondo di cartapesta. Un impegno che piace, se a cliccare sull’opera di Vito Bongiorno che ha concorso per il tema arte & crisi sono stati 3.500 utenti. Quasi un digipittore. Come ci sei riuscito? «Ho partecipato molto volentieri all’iniziativa di Inside Art “crisi, diamo voce all’arte”: è stato molto interessante per me vedere quanti digitolettori hanno votato il mio lavoro, Handle with care. Ma ancora più piacevole è stato leggere i loro apprezzamenti. Così ho letto di un’opera definita attuale, intelligente, chiara, forte, addirittura fonte d’ispirazione, tutto questo mi ha lusingato molto. Come ci sono riuscito? Diciamo che ho avuto l’impressione che mi bastasse invitare degli amici a vedere l’opera attraverso il vostro sito e poi che si espandesse a macchia d’olio, con una serie di voti, passaparola, apprezzamenti, condivisioni, messaggi e quant’altro».
Qualcuno l’ha definito l’Yves Klein italiano. Sarà per quel blu che spalma sulle sue opere al vivo, unico decoro su fanciulle che presenta come mamma le ha fatte. Ma oltre all’azzurro c’è il carbone, a raccontare i nostri misfatti ecologici e mettere in guardia sul futuro possibile per questo mondo di cartapesta. Un impegno che piace, se a cliccare sull’opera di Vito Bongiorno che ha concorso per il tema arte & crisi sono stati 3.500 utenti. Quasi un digipittore. Come ci sei riuscito? «Ho partecipato molto volentieri all’iniziativa di Inside Art “crisi, diamo voce all’arte”: è stato molto interessante per me vedere quanti digitolettori hanno votato il mio lavoro, Handle with care. Ma ancora più piacevole è stato leggere i loro apprezzamenti. Così ho letto di un’opera definita attuale, intelligente, chiara, forte, addirittura fonte d’ispirazione, tutto questo mi ha lusingato molto. Come ci sono riuscito? Diciamo che ho avuto l’impressione che mi bastasse invitare degli amici a vedere l’opera attraverso il vostro sito e poi che si espandesse a macchia d’olio, con una serie di voti, passaparola, apprezzamenti, condivisioni, messaggi e quant’altro».
Handle with care, un’Italia da maneggiare con cura. Perché? «Con questa opera ho voluto dichiarare lo stato di fragilità in cui versa il nostro paese, specialmente negli ultimi anni. Maneggiare con cura, dunque, un paese che quotidianamente affronta temi come la crisi a livello non solo economico ma soprattutto sociale e culturale. Dove la costruzione e la preservazione dei rapporti umani è passata largamente in secondo piano, lasciando il posto alla fretta, alla corsa all’acquisto, al consumismo globalizzato. All’usa e getta non solo per gli oggetti. Il sociologo polacco Zygmunt Bauman parla di una società liquida, io vorrei invece portare il pubblico, attraverso le mie opere, di fronte all’immagine di una società combusta e per questo fragile, come se da un momento all’altro potesse sgretolarsi. Ritengo responsabile di questa combustione il forte lassismo nei confronti di valori fondamentali come l’arte e la cultura da parte delle istituzioni. Si unisce a questa crisi una costante noncuranza del nostro patrimonio artistico e delle sue potenzialità, mai abbastanza valorizzate».
Dalle donne blu al carbone. Com’è andata? «Le donne blu sono state, per un periodo, una naturale conseguenza del mio lavoro sulle impronte. Attraverso le antropometrie e il “corpo pennello” delle mie modelle ho voluto sottolineare la predisposizione dell’uomo a lasciare impronte, segni materiali di un processo temporaneo che ha avuto luogo sul corpo e sullo spazio preso in considerazione. Le donne blu, inoltre, rappresentano per me un simbolo di purezza, perché penso che ciò che è puro sia semplice e pulito, ciò che è puro sia nudo. A un certo punto c’è un passaggio che mi fa pensare a come questa purezza possa toccare e nello stesso tempo trasformare quanto c’è di contaminato e fragile in questo momento sociale che l’umanità affronta. Da qui il carbone che simboleggia la malattia, la spaccatura, l’amarezza e l’inquinamento. Significativa, per questo passaggio, è stata una delle mie ultime performance: Terra mater alla Pelanda di Roma lo scorso maggio, in occasione della fiera Roma contemporary e in collaborazione con Inside Art. Nella performance una modella, simbolo della purezza, è dipinta di blu e si muove tenendo in mano un globo terrestre le cui terre emerse sono realizzate con il carbone, a significare l’inquinamento ecologico e sociale che caratterizza la nostra epoca».
Tra body e land art, racconta il tuo stile. «Attraverso la body art mi avvalgo del corpo come strumento per testimoniare il mio pensiero. Ma cerco, al tempo stesso, di estrapolarlo dalla sua materialità o sensualità, cercando piuttosto di coglierne la purezza che ne può scaturire e così portare un messaggio, spesso anche molto forte. In questo c’è una sorta di alchimia, c’è un passaggio del male, delle negatività, dell’inquinamento che attraverso la purezza del corpo si può tramutare in bene. Spesso uso l’ambiente come teatro dell’attività creativa. Per esempio nel 2002 a Tarquinia ho realizzato il dipinto più lungo del mondo: L’impronta degli Etruschi nel terzo millennio. Ho steso lungo la strada principale della città nove rotoli di tela di 50 metri l’uno, li ho cosparsi di colore e ho invitato le persone a passeggiarvi sopra, per lasciare le loro impronte, nel tentativo di rintracciare, per una sorta d’impenetrabile affinità strutturale sopravvissuta al tempo, le impronte dei loro avi. Dunque, per me la land art è una scenografia naturale e fondamentale per il mio lavoro. Spesso ho definito il mio stile come “sintetismo della vita” che esprimo nella sintesi fra esperienza oggettiva e manifestazione della propria interiorità. È comunque mia intenzione di ridurre l’importanza del manufatto artistico in quanto tale, sia esso un’antropometria, body o land art, un’installazione o un quadro, per privilegiare l’aspetto spirituale di ogni creazione. Nel mio stile diversi critici hanno colto elementi di essenzialità, leggerezza e istintività».
Veniamo allo spazio:?per te l’arte è un fatto mentale che va vissuto fuori da musei e gallerie. «Sì, perché per me è proprio la strada, lo spazio collettivo, il luogo dove s’imprimono le infinite tracce che formano il tessuto dell’esistenza dell’uomo. Attribuisco alla strada un valore poetico d’immagine, ed è proprio lì che si estendono i confini tra il mondo dell’arte e la quotidianità. La strada, o comunque i luoghi non designati prettamente all’arte, sono spesso lo spazio ideale in cui posso portare il mio pensiero, la mia pittura, lasciando emergere in maniera forte l’essenza dell’opera stessa, lasciandole solo l’esistenza oggettiva».
Dalla Sicilia a Roma, andata e ritorno (con l’opera Oltremare a Gibellina). Che trovi e che riporti? «Sono nato ad Alcamo il primo dicembre 1963 e ho vissuto in questa splendida cittadina i primi anni della mia vita. Quando ci siamo trasferiti a Roma avevo sette anni ma già avevo vissuto per circa un anno in Germania per motivi legati al lavoro di mio padre, nella città di Koblenz, per tornare ancora una volta in Sicilia fino all’età di cinque anni, dunque al fatidico gennaio del 1968, anno del terribile terremoto della Valle del Belìce. Dopodiché, ci siamo trasferiti a Genova per altri due anni e da qui definitivamente a Roma. Gli anni della mia infanzia sono stati assai movimentati. Nel passaggio dalla Sicilia alla capitale sicuramente ciò che ho sempre sentito è stato una sorta di strappo; ogni volta che ho lasciato questa terra, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e a qualsiasi età, mi sono sempre trascinato dietro, come una coperta, un manto pesante di emozioni nostalgiche e forti. Della Sicilia mi mancano soprattutto i colori, l’odore del mare e quel caldo e indescrivibile abbraccio fatto di scirocco e profumi di zagara. Oggi ho la fortuna di tornarci di tanto in tanto. Durante uno dei miei viaggi in Sicilia, tre anni fa, nel luglio 2009, mi sono ritrovato a camminare all’interno della meravigliosa opera di Alberto Burri: il Grande cretto di Gibellina. Camminare nella desolazione di quel paese dimenticato e ormai ridotto a sole macerie mi ha fatto pensare a quanto era stata terribilmente avversa la natura in quella valle. Nella parte delle case crollate e tra le macerie ho colto e raccolto alcuni elementi e con questi ho realizzato la mia opera. Così, per rispondere alla tua domanda “che trovi e che riporti?”, potrei risponderti in questo modo: un terremoto. Perché il terremoto del 1968 mi è rimasto dentro. All’epoca avevo quattro anni: ricordo le notti fredde, cioccolata calda e un’Ape che ci portava fino al mare, ospiti da una zia. A distanza di molti anni, vivendo a Roma, ho trovato nell’arte la mia espressione, e questo mi ha dato la possibilità di esprimere quella catastrofe attraverso il mio lavoro, in Sicilia. Sempre in quel luglio Ludovico Corrao, già sindaco di Gibellina dal gennaio del 1968 fino agli anni ‘80 e presidente del museo delle Trame mediterranee della fondazione Orestiadi di Gibellina, ha acquisito una mia opera, intitolata emblematicamente “Oltremare a Gibellina”. In questo quadro ho voluto far emergere dal blu del mare un orizzonte lontano, oltremare appunto, un blu che avesse la forza di portare oltre la catastrofe e le macerie un paese che è stato ricostruito e risollevato anche e soprattutto attraverso l’arte».
Se fossi un colore, saresti blu Bongiorno? «Se fossi una canzone, sarei Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Ironia a parte, sicuramente il blu è il colore che amo più di altri, perché mi riporta alle mie origini, ad Alcamo, città dove sono nato e dove il blu del cielo e del mare è intenso, profumato e puro. A volte, mi sembra attraverso questo colore di poter respirare i profumi e gli odori della mia terra, la Sicilia. Il mio è un blu silenzioso che mi calma ma allo stesso tempo mi dà energia, questa sua duplice essenza a volte lo rende inquietante».
Tra i tuoi maestri citi Delle Site, Scialoja e Klein. «Avendo manifestato sin dall’infanzia inclinazioni al disegno e alla pittura sono stato avviato da mio padre agli studi artistici. Mi sono diplomato nel liceo artistico statale di largo Pannonia a Roma, dove ho avuto la fortuna di avvalermi, tra i miei insegnanti, anche del maestro Mino Delle Site, il celebre aeropittore futurista. Da Delle Site, lo scrittore e filosofo Costanzo Costantini ha scritto che ho preso, o appreso, soprattutto la leggerezza peché definisce la mia mano, nel segno e nella pittura, leggera come l’aria. A differenza di Delle Site, Toti Scialoja, il pittore delle impronte, non è stato mio maestro ma potrebbe esserlo, visto il lavoro intenso che ho svolto sulle impronte. Il segno, così come l’impronta, è una traccia, un’ombra della realtà; spesso attraverso questo concetto mi sono sentito vicino all’opera di Toti Scialoja, soprattutto là dove, come lui dichiarava, il gesto o il segno precedono il pensiero. Il mio lavoro si è incentrato, per un lungo periodo, sul tema dell’impronta, questo mi ha permesso di portare in rassegna il reale nei diversi aspetti della sua totalità espressiva. A proposito di Yves Klein, invece, come lui, oltre la pittura, coltivo interessi come le arti marziali giapponesi, la musica, le dottrine alchemiche e la fotografia. Il discorso delle antropometrie è stato piuttosto un percorso obbligato visto l’uso delle impronte nella mia pittura, già in tempi lontani, attraverso elementi diversi come materiali da recupero. Così è arrivato anche l’uso del corpo umano in una forma assolutamente naturale; ho colto l’esperienza e l’esempio di Yves Klein anche in questa ricerca artistica».
Fino a poco tempo fa comparivi tra gli artisti amici di Casa Pound. «La mia arte è apolitica, non sono un amico di Casa Pound, tutt’altro. Mi è successo addirittura di allontanarmi, nel corso di una mostra, per le innumerevoli e non condivise simbologie utilizzate da loro. In ogni modo considero il futurismo, un importante movimento artistico italiano ed per questo ho colto l’invito alla mostra Futur ardita, rassegna di donne e futurismo al Circolo futurista di Roma per la celebrazione del centenario del manifesto omonimo, nel 2010, evento patrocinato dall’assessorato alle Politiche Culturali e della comunicazioni del comune. Nell’occasione ho portato, in una performance, le antropometrie concernenti la visione di una donna moderna, simbolo dall’avanguardia artistica e culturale italiana del XX secolo che ha caratterizzato il futurismo. Ricordo bene quella performance e la tela che ne è scaturita l’ho donata a Francesca Barbi Marinetti, nipote di Filippo Tommaso Marinetti. Sempre nello stesso anno, 2010, ho accolto diversi inviti per l’anniversario e attraverso i miei lavori ho portato il mio omaggio al futurismo Italiano. Così sono rimasto registrato sul loro sito come artista amico, quando me ne sono accorto mi sono fatto cancellare».
A proposito di futuro, quali sono i tuoi progetti? «La situazione catastrofica che in Europa e soprattutto in Italia nuoce alla cultura e quindi all’arte mi ha portato a ragionare sul valore degli ultimi artisti italiani del XX secolo. La mia attenzione è caduta su un artista deceduto da pochi anni, Gino De Dominicis, che aveva intuito gli equivoci del sistema dell’arte italiana. In proposito, a settembre, ho anche esposto alla mole Vanvitelliana di Ancona, in occasione di una mostra dedicata a lui. Federica Gerace, che è stata molto vicina all’artista, mi ha proposto la realizzazione di un filmato che, partendo dall’idea dominicisiana di matrice concettuale, finisce con il racconto di una quotidianità vissuta dagli artisti in un modo sentimentale e passionale ma distante e gelido verso la realtà. Il filmato, dedicato all’artista scomparso, è un modo di verificare la continuità del suo messaggio artistico, indispensabile in un momento storico italiano caratterizzato da una profonda apatia del pubblico rispetto al fenomeno dell’arte sminuito dalle problematiche economiche che non stimolano a una vera riflessione sul concetto di arte ma a una fruizione distante e superficiale. Il filmato potrebbe rappresentare una gradita sorpresa per gli amanti dell’arte e per i collezionisti; speriamo potrà poi passare per musei e fondazioni. Ci auguriamo di portarlo anche a Venezia, alla prossima biennale, essendo la città più amata in assoluto dall’artista. Oltre a questo progetto due curatrici, Lory Adragna e Maria Arcidiacono, stanno portando avanti la realizzazione di una mostra duale, alla Bibliothè di Roma per il ciclo Gimnosofisti. Inoltre, sempre a Roma ho in programma un’esposizione con Franco Losvizzero in un importante spazio pubblico, che non dico per scaramanzia, per la prossima primavera, ancora a cura della Adragna e di Claudia Quintieri».
Tutte le info di Vito Bongiorno a Tarquinia con Inside Art