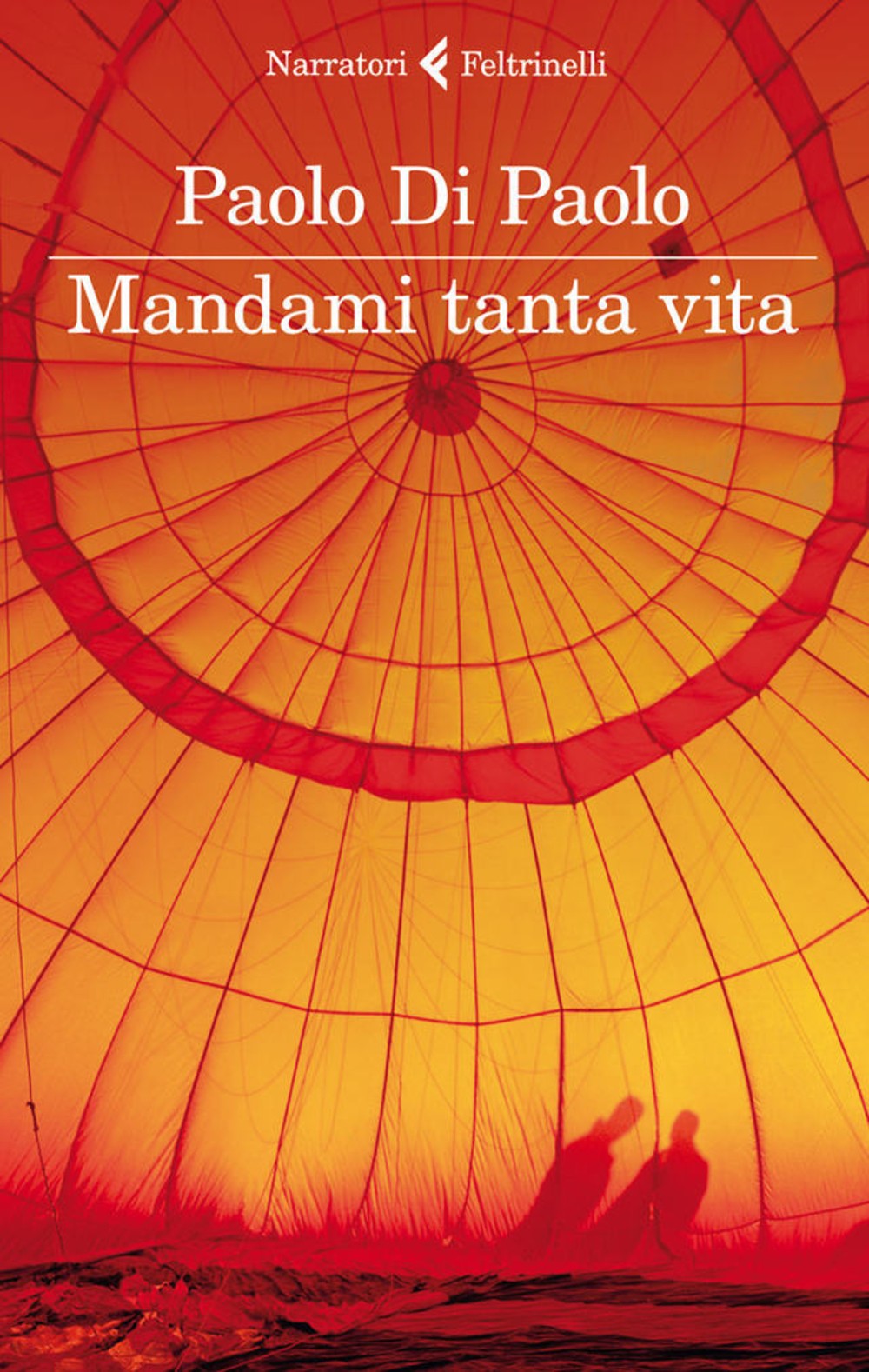
Paolo di Paolo ha messo su un romanzo che comincia dal titolo stampato sulla copertina. Mandami tanta vita è scritto in bianco sopra la foto di una mongolfiera arancione e il sotto il nome dell’autore. Entrato nella cinquina finale per lo Strega, lo scrittore, con i suoi trent’anni, è il più giovane fra tutti i finalisti. Lontano dall’essere la sua prima prova, il romanzo è preceduto da altri scritti e una collezione di partecipazioni in finali di grandi premi letterari come il Campiello e il premio Italo Calvino. Questo per dire che Di Paolo non è certo uno sconosciuto, tanto da avere una voce su Wikipedia (cosa che non vantava, per esempio, la più giovane della scorsa edizione dello Strega, Lorenza Ghinelli) e che non è certo dal primo romanzo che riesci a far partire una storia dal titolo.
Mandami tanta vita, messo così sulla prima pagina, scinde il mondo in due personaggi, chi ha vita da vendere e chi di vita ne ha così poca da chiederne. In questa sorta di squilibrio che anima la nostra terra è chiaro quale sia la parte scelta da Di Paolo, quella del richiedente, del malato se vogliamo. Così, senza neanche aprire il libro si ha già chiara la struttura elementare che regge la trama del testo, fondata, dunque, su una divisione impari di energie (vitali e mentali) che come l’amore in Dante move il sole e l’altre stelle, spingendo i protagonisti a cercarsi e allontanarsi per tentare un equilibrio. E poi, ma bisogna essere veramente bravi, sempre dal titolo, possiamo capire il protagonista del romanzo, cioè l’autore delle tre parole in copertina, cioè Piero Gobetti.
Difficile raccontare qui la storia di Gobetti, morto giovanissimo a 25 anni espatriato a Parigi perché perseguitato dai fascisti a Torino dove lavorava come editore con idee non proprio fascistissime. Piero però nel romanzo non è l’unico protagonista, ruolo che divide con Moraldo, un giovane ragazzo frutto della fantasia dell’autore. I due sono le colonne delle 155 pagine, ognuna delle quali porta avanti nel testo un’ossessione e un amore. L’idea di capire se stessi anima i pensieri di Moraldo, riflessioni distratte da una giovane fotografa che lo porterà a Parigi. Piero coltiva l’amore per sua moglie e suo figlio appena nato, mentre l’ossessione di informare l’Italia sui danni di un totalitarismo lo costringe a fuggire nella capitale francese. E sarà proprio nella ville lumiere che Moraldo, dopo tanti tentativi falliti, incontra per caso l’editore, il suo mito, quello con cui è dispoto a pubblicare tutto, dalle caricature che disegna ai pensieri che scrive. Antonio Tabucchi non ha avuto molti seguaci, uno dei pochi è Paolo di Paolo e l’incontro fra i due, ciò che non si dicono, quello che non fanno deve tantissimo allo scrittore scomparso.
Il romanzo scivola via in una lettura che non incontra intoppi ma dove brillano delle frasi felici (“anche lo spazio ha vissuto incertezze”) alternate a periodi meno riusciti (“tienimi stretto come fossi il tuo bambino”). Forse la dote più grande dell’autore è quella di spezzare la trama del racconto con improvvise aperture che spostano il lettore verso un tema insignificante ai fini narrativi ma fondamentale per la costruzione di un’atmosfera. È appena nato il figlio al venticinquenne Piero che si appresta a entrare nella sala parto. “Avverte, senza volerlo, qualcosa di sacro in tutto questo, Natale è trascorso da appena tre giorni: entra nel quadro come padre e come pastore adorante, scosso, nella stessa luce tenue di una tela di Tiziano visto a Londra l’estate scorsa”. Oppure sempre parlando dell’editore già a Parigi e dopo una visita al Louvre “è preso dal desiderio febbrile di rimettere mano agli appunti sulla pittura, ha il taccuino con sé, ne sfoglia rapidamente le pagine, il vento sul pont des Arts ha cominciato prima di lui”. Questo spaesamento continuo e uno stile omogeneo (dove a volte esce fuori lo sforzo di rimanere dentro uno schema autoimposto) regala al romanzo un colore bruno, un’atmosfera malinconica e sfumata che regge tutto lo scritto come una dominate nelle composizioni musicali.
Sarà questa impossibilità di cogliere un senso più largo che spinge Di Paolo a concentrarsi sulle cose, le piccole cose a metà fra Gozzano e Perec. Un’attenzione che è quasi morbosa nel descrivere oggetti che diventano unità di misura minima per presentare una stanza o un paesaggio. È anche grazie al diverso rapporto dei due protagonisti con le cose che vengono definite le loro personalità. Significativo l’incontro fra Moraldo e la fotografa avvenuto per uno scambio di valige. Riflette Moraldo: “Che strano, pensa: di me ha visto solo vestiti e biancheria, puro contenitore, e mi sento esattamente come se avesse visto il contrario, come se avesse visto il mio corpo nudo, senza vestiti ne biancheria, puro contenuto”. Cioè, vestiti e biancheria (possiamo chiamarle cose) raccontano una persona. Se questo è vero per Moraldo (a conferma c’è un passaggio nel quale il protagonista aspira a trasformarsi in un oggetto: “ La soluzione sarebbe perdersi in tutto questo mercato del mondo fino a scomparire (…) come una moneta da collezione, un organetto di Barberia scassato, un coltello arrugginito, un pallone sgonfio”) se è vero per Moraldo, però, non lo è per Piero, anzi, vero per l’editore è il contrario. Gli oggetti per il rivoluzionario sono un ostacolo, un problema, tanto che dopo una partenza essenziale da Torino per Parigi, una volta nella città, per trasportare gli arredamenti dovrebbe spendere 8mila franchi e del tempo prezioso che vorrebbe dedicare solo allo studio.
Questa particolare attenzione, da parte di Di Paolo, verso dati puramente descrittivi e una trama essenziale, in parte tratta dalla vita di Gobetti e quindi non inventata dall’autore, sembra un punto di partenza verso una sperimentazione del romanzo che se riesce ad abbandonare definitivamente una narrazione arriverà a esiti interessanti.


